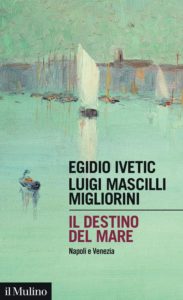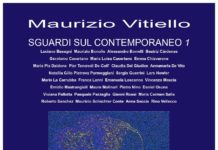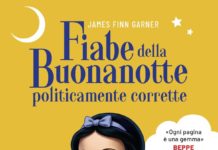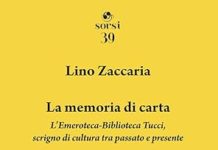La storia – e prima ancora il respiro salmastro – delle città di mare e di costa mi affascina da decenni. Le osservo e le studio nelle implicazioni economiche e sociali comparando scelte urbanistiche, politiche industriali, evoluzioni culturali, movimenti artistici e scie letterarie.
Guardo con curiosità e ammirazione ai luoghi crocevia di genti e popoli che hanno originato contaminazioni linguistiche, gastronomiche, musicali e antropologiche dando vita a realtà ricche di inventiva, ibridazioni e spontanea circolazione di idee, religioni e visioni.
Da napoletana trasferitasi in un luogo lontano dal mare ho scoperto la cifra identitaria che il Mediterraneo rappresenta, ho provato le fitte di un’assenza fisica e spirituale e vissuto la perdita di un allontanamento calcificatosi in perdita. Una mutilazione liquida.
Leggere il lavoro di Egidio Ivetic e Luigi Mascilli Migliorini “Il destino del mare. Napoli e Venezia” pubblicato da Il Mulino è stato un vero piacere, ho ascoltato la voce di due storici appassionati raccontare luoghi con il sentimento di chi lotta affinché la turistificazione – e il consumismo senz’anima che spinge visitatori vaganti alla ricerca di selfie sensazionali senza nessun interesse per l’anima del paesaggio sullo sfondo – non prevalgano cancellando la meraviglia e lo stupore per i secoli di storia che le coste delle nostre città custodiscono.
Tanti sono gli aspetti che accomunano Napoli e Venezia, alcuni tangibili altri spirituali ma, quel di cui trattano gli autori, è il rapporto che queste hanno con il mare. Una relazione, in entrambi i casi, sofferta.
Napoli in periodi alterni – e Venezia dal tramonto della Serenissima in poi- sono state separate dal loro mare attraverso un waterfront che è linea di confine e frattura: «Il leone si era interrato. Per quanto i fiumi non abbiano interrato lo specchio salmastro della laguna, si era interrato lo spirito» scrive Ivetic a proposito del leone di san Marco e «Nell’arco di due decenni Napoli venne quindi a perdere tutto il litorale e divenuto irriconoscibile, o meglio sconosciuta alle generazioni di napoletani che seguiranno. Diventò una città di mare che poteva essere utilizzata solo come punto di vista del suo meraviglioso golfo…» scrive Mascilli Migliorini descrivendo il mare che bagna (?) Napoli.
Entrambi concludono le loro analisi con un agrodolce sapore di nostalgia per lo sperpero di una storicità culturale nata sulle sponde del Mediterraneo, da millenni, centro di civiltà e diversità.
Napoli è stata terra di conquista e dominazione in cui il mare è orizzonte da cui sono comparsi i greci che l’hanno fondata e i saraceni che minacciavano le popolazioni costiere, via di comunicazione aperta e costante con la Spagna durante il Regno delle Due Sicilie, via di fuga in caso di pericolo, teatro operativo per le battaglie navali e centro nevralgico per lo sviluppo di commerci e scambi.
Venezia è stata la Dominante, la porta dell’Oriente che con la supremazia marittima ha creato un impero e un complesso sistema sociale, il perno della costruzione di un arco in continuità con l’Istria e la Dalmazia che ha disegnato un’identità che trascende le linee tracciate dai cartografi scrivendo la storia dei territori che oggi conosciamo come Balcani – per gli Ottomani Rumelia, terra romana quindi cristiana – il cui il mare per Ivetic è membrana: «Tutto l’alto Adriatico è una regione economica, con all’interno queste complementarietà, quasi spontanee tra le terre venete e friulane e l’Istria. In mezzo, Venezia, grande mediatrice. Ed è da questo nucleo marittimo, una sorta di seconda membrana rispetto a quella primordiale lagunare, che la città di san Marco ha imparato ad affermarsi nell’Adriatico».
Ma se lo sviluppo partenopeo, nelle sue articolazioni terrestre e marittima, non assume una specifica connotazione linguistica cosa diversa è per Venezia che fonda uno Stato da Mar composto da città e isole sparse nel Mediterraneo: Dalmazia, isole Ionie – Corfù, Paxo, Itaca, Zante, Cefalonia etc – Peloponneso, Egeo, Cicladi e Cipro che fu veneziana per oltre un secolo (1474-1573): «Tutto il sistema era, dall’Istria a Cipro, un arcipelago. Lo Stato da Mar fu un limes, la prima linea di difesa della cristianità nel Mediterraneo, mentre la seconda linea corrispondeva al Regno di Napoli e a Malta. Fu davvero il mare reso in Stato».
In queste ultime parole è racchiusa l’essenza di Venezia: essa fu il suo mare, un mare conquistato dopo aver superato la propria identità lagunare. Venezia conviveva con la Sublime Porta, dotata di ambascerie e un capillare apparato diplomatico amministrava territori vicini e lontani anche attraverso una impalcatura simbolica di cui l’annuale sposalizio con il mare, celebrato con la processione del bucintoro del doge, è valido esempio.
E, soprattutto, Venezia come Napoli sfugge all’esercizio della facile categorizzazione, l’operazione dell’incasellare in definizioni volte a semplificare poiché esse furono – e sono – complessità e stratificazione che incarna e testimonia il sincretismo.
Se Partenope è luogo in cui convivono l’eredità etrusca, greca, sannita, romana, bizantina, normanna, sveva, angioina e spagnola: «Venezia semplicemente non è Occidente, non lo è abbastanza, secondo una logica rigorosamente occidentale […] Venezia deriva dal mare, dall’Oriente, dal Mediterraneo».
Il destino del mare è il destino degli insediamenti umani che sulle sue coste nascono, si trasformano e muoiono, a loro – a noi – spetta il decidere come vivere il rapporto con le acque salmastre di cui siamo impastati: «Venezia e il mare oggi sembrano due cose diverse, per quanto unite».
Anche per Napoli è così, il mare lo si vede ma è diviso dalla città, tenuto separato come elemento altro ed è un’alterità dal valore non neutro, è scelta consapevole. Leggere la storia ci aiuta a comprendere chi siamo e perché siamo.
Come Mascilli Migliorini credo che le sirene non nuocciano, di più sono convinta che sirene si nasca anche oggi e che Partenope non si sia suicidata, di quel vile di Ulisse non si è mai interessata, omuncolo da poco.
IL LIBRO
Egidio Ivetic, Luigi Mascilli Migliorini
“Il destino del mare. Napoli e Venezia”
Il Mulino
Pagine 176
euro 16
GLI AUTORI
Egidio Ivetic insegna Storia del Mediterraneo nell’Università di Padova. Con il Mulino ha pubblicato in anni recenti: «Storia dell’Adriatico» (2019), «I Balcani» (2020), «Est/Ovest» (2022), «Il grande racconto del Mediterraneo» (2022), «Studiare la storia del Mediterraneo» (2024) e «Sud/Nord» (2024). Luigi Mascilli Migliorini, membro dell’Accademia dei Lincei, è professore emerito dell’Università di Napoli – L’Orientale. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo «Storia del mondo» (con F. Canale Cama e A. Feniello, Laterza, 2019), «Napoleone» (Salerno, 2021) e «11 maggio 1860» (Laterza, 2023).