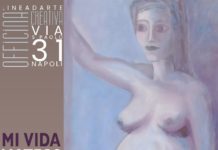Capodimonte è un grande cantiere e coinvolge sia la struttura museale sia lo spazio che lo circonda. Il rifacimento dei viali di accesso al Museo costringe ad un tortuoso percorso prima di raggiungere lo spazio verde che viene inaugurato vicino al Palazzo dei Principi, il grande assente di questi anni.
Il pensiero torna a giovedì 21 luglio 2022, quando nel Salone delle feste del Museo, la collezionista Lia Rumma annunciò, alla presenza di Massimo Osanna (direttore generale dei musei), Onofrio Cutaia (direttore della creatività contemporanea), del sindaco Gaetano Manfredi e del direttore del Museo e Real Bosco di allora, Sylvain Bellenger, una delle donazioni più importanti dal dopoguerra per l’arte contemporanea italiana. In quell’occasione, si affermò che la Collezione Rumma sarebbe stata esposta, una volta completata la ristrutturazione nel 2024, nella Palazzina dei Principi, situata a breve distanza dalla Reggia.
Seconda solo alla Reggia per prestigio e posizione, la palazzina dei Principi si distingue per la sua sobria eleganza. Con circa 4.000 m² di superficie, fu costruita nel XVII secolo per volere dei marchesi Carmignano di Acquaviva. In seguito divenne una delle ville suburbane più celebri delle colline napoletane, e fu acquistata dal re durante la costruzione del Palazzo Reale di Capodimonte. Il nome deriva dai principi reali — figli di Francesco I di Borbone — che vi risiedettero dal 1826. Di quel progetto[1], così come di quello della Città-Museo, si stenta oggi a seguire gli sviluppi, nonostante la sua ambiziosa visione educativa, divulgativa e di ricerca.
Accanto alla palazzina, nel Real Bosco di Capodimonte, si trova il giardino dei Principi, storica area del parco, recentemente restaurata. Durante l’inaugurazione, il ministro della cultura Alessandro Giuli — presente brevemente per altri impegni — ha dichiarato che questa giornata è una festa per la restituzione ai cittadini di un paesaggio meraviglioso, ricco di biodiversità fin dalle origini. Ha sottolineato come il ministero abbia saputo ben investire i fondi del pnrr nella rigenerazione paesaggistica e museale.
Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania, che dopo l’Inno Nazionale ha eseguito altri brani musicali.
Il direttore del Museo, Eike Schmidt, ha ricordato che i lavori di restauro del giardino dei Principi — durati un anno — rientrano nei 25 milioni di euro del pnrr assegnati direttamente dal ministero al Museo per il più vasto intervento di sistemazione dei viali e dell’architettura vegetale mai realizzato a Capodimonte.
La direttrice dei lavori, Eva Serpe, ha illustrato l’ispirazione ottocentesca del progetto, basato sui disegni di Friedrich Dehnhardt che ha progettato l’area. I viali sono stati realizzati senza massetto, con un mix di tufo, sabbia, pietrisco e legante per favorire la permeabilità dell’acqua. È stata riattivata una delle 319 fosse drenanti originarie: tutte saranno progressivamente ripristinate, in linea con l’obiettivo del pnrr di recuperare la risorsa idrica.
In parallelo, si è recuperato il disegno vegetale originario, con scorci paesaggistici tipici del progetto di Dehnhardt e un sottobosco ripiantumato in grado di autorigenerarsi.

Secondo Angelantonio Orlando, direttore generale e referente per l’attuazione del pnrr, il finanziamento di 300 milioni per parchi e giardini — il più grande mai fatto in Europa — ha destinato 25 milioni al Bosco di Capodimonte. Parte di questi fondi è servita per piantare nel solo Giardino dei Principi 62 alberi, 2.450 arbusti e 2.465 essenze erbacee. Entro la fine del progetto si arriverà a oltre 10.000 alberi, 7.600 arbusti e 43.000 essenze erbacee complessive. Di rilievo anche la scelta di essenze erbacee a basso fabbisogno idrico, in collaborazione con l’Università Agraria.
Luigi La Rocca, capo del dipartimento tutela patrimonio culturale, ha sottolineato come il parco sia stato strappato al degrado e al vandalismo. Tra i progetti più ambiziosi spiccano: la ristrutturazione della Chiesa di San Gennaro con l’allestimento di Santiago Calatrava, il recupero della Tisaneria e della Real Fruttiera dei Borboni. L’obiettivo è rendere Capodimonte sostenibile economicamente ed energeticamente, in equilibrio tra tutela, valorizzazione e innovazione.
Alfonsina Russo, del dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, ha ricordato che i finanziamenti hanno acceso nuova consapevolezza: i giardini vengono finalmente riconosciuti come musei a cielo aperto. La partecipazione al progetto Garden Route Italia mira a valorizzare giardini e parchi poco noti, contrastando l’over tourism, che concentra le escursioni in alcuni posti e in alcuni luoghi, e favorire un turismo sostenibile e diffuso, anche nelle periferie.
La collina di Capodimonte, nonostante l’aggressione edilizia, rimane oggi un luogo straordinario. La scelta di Carlo di Borbone di costruirvi una reggia si rivela strategica: panoramica, salubre, adatta alla caccia — non solo passione reale, ma vera e propria funzione di Stato che coinvolgeva ministri, nobili, artisti e ospiti illustri oltre ad artisti e pittori chiamati a ritrarre la scena come una cerimonia ufficiale.
Nel 1736, due anni dopo l’ascesa al trono di Carlo, la tenuta era già delimitata. I lavori del Real Palazzo iniziarono nel 1738 nello “Spianato”, la zona più panoramica del sito. Bosco e Reggia, inizialmente separati, divennero un’unica entità durante il decennio francese, grazie alla costruzione del muro di cinta e l’apertura delle porte su Ponti Rossi e Miano. Sarà Ferdinando II, dal 1830, a completare l’edificio.
Oggi il Real Bosco di Capodimonte si estende su 134 ettari e vanta circa 400 specie vegetali, suddivise in 108 famiglie e 274 generi. All’interno del suo perimetro si contano sedici architetture, tra cui residenze, casini, fabbriche artigiane, depositi, chiese, fontane, statue, dispositivi per la caccia, orti, frutteti e persino un cimitero: quello dei Cappuccini dell’Eremo. Sparse nel verde, queste strutture erano destinate a diverse funzioni: la vita di Corte (Casina della Regina, Palazzina dei Principi), la produzione (Manifattura di Porcellana), il culto (Chiesa di San Gennaro, Eremo dei Cappuccini), l’agricoltura e la zootecnia (Fagianeria, Cellaio, Vaccheria).
Le diverse zone vegetali del bosco erano funzionali ai tipi di caccia praticati dal re: a boschi fitti di lecci, castagni, carpini e olmi seguivano aree coltivate con mirto, olivella e lauro regio, alternati a radure e spazi per la caccia, come le ragnaie[2].
Grandi porzioni del bosco venivano coltivate per l’alimentazione degli animali, domestici e selvatici, custoditi in recinti e serragli. I prodotti della terra servivano sia alla Corte sia alla vendita.
La trasformazione della riserva di caccia in parco reale è stata opera di Sanfelice che, grazie alla sua formazione anche di scenografo, inventa il nucleo centrale dei viali a ventaglio, attraversati da viali perpendicolari e trasversali che formano altre geometrie autonome. Crea punti di fuga prospettici, luoghi di affaccio panoramico «così da combinare, col gusto tradizionale per l’ordinata e simmetrica struttura prospettica del “giardino all’italiana” riadattato su esempi francesi, l’interesse più recente, già d’inclinazione romantica, per l’aspetto apparentemente spontaneo del “giardino all’inglese[3]”».

Tra le figure fondamentali nel panorama napoletano spicca Friedrich Dehnhardt (1787–1870), giardiniere botanico originario di Göttingen. Dopo la formazione a Schönbrunn e un periodo a Milano, giunse a Napoli nel 1811 come capo giardiniere dell’Orto Botanico. Divenne noto per l’introduzione del giardino paesaggistico all’inglese, ottenendo nel 1813 la nomina a ispettore delle piantagioni della Real Passeggiata di Chiaia. Troppo poco il tempo per i re francesi per portare a termine anche altre iniziative, come il disegno a giardino dei nuovi terreni acquisiti sullo spazio collinare reale, che avviene anni dopo.
Il suo lavoro a Capodimonte inizia nel 1840, quando viene nominato giardiniere capo, con incarico sul giardino all’inglese di due ettari attorno al Casino dei Principi. Dehnhardt introdusse ampie aiuole sinuose e piante esotiche come eucalipto e thuja. I nuovi impianti valorizzavano la vista del Vesuvio, elemento centrale del progetto: il prato si alterna al bosco, adattandosi al terreno e punteggiandosi di grandi alberi isolati che incorniciano lo scenario.
Con la riapertura del giardino dei Principi, torna in vita un frammento prezioso del paesaggio napoletano, un luogo immersivo di conoscenza, bellezza e memoria.
Un simbolo straordinario di questo giardino è il Canforo (Cinnamomum camphora), maestoso esemplare alto circa 18 metri, piantato agli inizi del 1800 nei pressi dell’entrata posteriore del Casino dei Principi. Originario della Cina, è oggi uno degli alberi iconici del parco, protagonista anche di celebri pitture. La sua età e le sue dimensioni ne fanno un micro-ecosistema, con muschi, felci e funghi che ne popolano i rami, rendendolo interessante anche dal punto di vista ecologico.
Nel giardino dei Principi tra gli altri alberi monumentali si contano: – la Melaleuca, detta “albero della corteccia di carta”; – il Cipresso di Montezuma, nei pressi della “Casa del Giardiniere”, riconoscibile per la particolare appendice detta mucrone; – l’Eucalipto robusta, alto circa 30 metri, con fusto di 330 cm di circonferenza; – il Tasso, una delle poche specie autoctone presenti, con dimensioni imponenti (10 m d’altezza e 250 cm di circonferenza).
A Capodimonte l’arte e la natura si fondono in un microcosmo armonioso. Il Giardino dei Principi è un gioiello che invita alla riflessione: i suoi alberi secolari conservano la loro forma nel tempo, in un’esistenza che resiste, mentre tutto attorno muta. Un simbolo profondo della continuità tra generazioni, capace di ispirare scelte più consapevoli — sia personali che collettive.

NOTE
[1] https://www.ilmondodisuk.com/museo-e-real-bosco-di-capodimonte-la-collezione-rumma-entra-nella-palazzina-dei-principi-circa-settanta-opere-di-artisti-italiani-contemporanei-dal-1965-agli-anni-2000/
[2] La cosiddetta ragnaia è un elemento tipico dei giardini storici italiani. Si trattava di un boschetto con alberi ad alto fusto, piantati abbastanza fittamente, tra i quali venivano stese delle reti per la cattura di piccoli uccelli (aucupio), dette “ragne”, in quanto ricordavano le ragnatele, da cui il nome.
[3] Museo Nazionale di Capodimonte, a cura di N. Spinosa, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia, Electa Napoli, 1994 pag.8