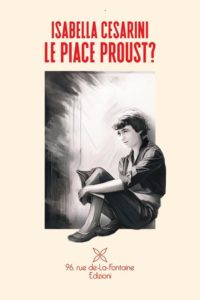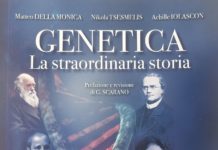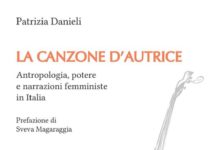Non so se capita anche a voi, terminata la lettura di un romanzo, di avvertire la storia che vi aleggia intorno, uno sfarfallio di pensieri, un palpitare di immagini e suggestioni che vi accompagna per il tempo necessario a definire le sensazioni che le pagine hanno rilasciato, una pausa dedicata a distillare e archiviare nella memoria scegliendo la categoria di pertinenza: bella e struggente, emozionante e avventurosa, poetica, eccitante, inutile e prolissa, sopravvalutata, melensa, commerciale, insipida e senz’anima.
“Le piace Proust?” di Isabella Cesarini, pubblicato da 96 Rue de-La-Fontaine, è tra quelle che ho catalogato alla voce intensa, raffinata, intimista e con una scrittura che risveglia il piacere della lettura.
L’autrice racconta Françoise Sagan, nata Françoise Quoirez, sgomberando subito il campo dall’errata convinzione che la scelta del nom de plume derivasse dal principe Sagan de la “Recherche du temps perdu” di Proust, era la principessa, dettaglio non trascurabile.
Il romanzo biografico è costruito sul dialogo interiore della scrittrice che, a pochi giorni dalla morte, ripercorre le scelte d’amore vissute con i due mariti e le due donne amate, i successi, le critiche e la propensione per il vizio confessando che no, non è vero che le critiche non la ferissero, le lasciava scivolare addosso mostrando disinteresse ma dentro le bruciavano come a quasi tutti gli esseri umani dotati di amor proprio e sensibilità accade.
Sagan arrivò al successo da ragazza, a diciannove anni come Mary Shelley ma nel suo caso l’editore non temette che denunciando il sesso dell’autrice il libro non si sarebbe venduto, i tempi per fortuna erano cambiati e “Bonjour tristesse”, pubblicato nel 1954 e messo all’indice per il suo contenuto scandaloso dal Vaticano, si vendette e non solo in Francia.
Avendo avuto la fortuna di crescere in una casa in cui tutti leggevano in assenza di restrizioni e censure lo lessi da adolescente, ne ricordo la copertina dell’edizione pocket Longanesi con la coccarda rossa ma non la scandalosità.
«Il Daily Mail commentò il testo, o dovrei dire commentò la scrittrice Sagan ˂come una ragazza che ha la parola sesso stampata nel cervello˃ […] Credo che il giudizio sull’opera fosse il risultato di uno sguardo posto nella prospettiva sbagliata, quella della paura: la paura del desiderio e pertanto del peccato. Tuttavia, oggi, dal ballatoio della mia ammaccata senilità, mi rendo conto che non sono ancora riusciti a vedere l’unico scandalo, nonché il peggiore: la manipolazione».
La manipolazione è quella di Cécile che con le sue macchinazioni conduce la storia a un esito tragico, questo è quello che ricordo: il tirare i fili pensando di essere burattinaia in grado di controllare il gioco muovendo le persone secondo le traiettorie disegnate per loro.
La nota di fondo che ho archiviato nella memoria riguarda la costruzione di circostanze volte a condurre i personaggi verso il risultato voluto non tenendo in nessun conto sentimenti, desideri, sogni e aspettative altrui disconoscendo l’imponderabilità della scelta del singolo individuo.
Era scandaloso che delle donne potessero avere pulsioni uguali a quelle degli uomini infrangendo le regole sociali? «Scrissi delle donne come avrei scritto degli uomini, oppure trattai le donne come avrei trattato gli uomini: io vedevo creature e non sessi. E se la creatura uomo aveva voglia di consumare la notte con una sconosciuta, perché la creatura donna non poteva comportarsi alla stessa maniera? […] il senso di colpa non porta il maschile o il femminile».
Già, perché una donna non poteva comportarsi alla stregua di un uomo? È l’interrogativo che conduce alla strada della disobbedienza che tanto mi infiamma anima e cuore. Cesarini cesella le parole con cui la protagonista rimembra, paragona, ragiona e riflette affrontando temi e argomenti che offrono spunti interessanti, profondi e mai grevi donando la piacevolezza di una lettura lontana dalla dilagante banalità e ridondanza.
Tra questi vi sono le considerazioni sull’artista: «L’artista non è vuoto, l’artista è eccessivamente pieno. È tenuto a governare il rumore di tutte le esistenze che lo abitano», e ancora «La creatura talentuosa sovente non sa di esserlo; proprio grazie a quella dote, non si riconosce tale. La grandezza non si manifesta nella coscienza. La grandezza è bottino dell’altrui sguardo». Altrettanto pregnante è il soffermarsi sulla sottile differenza tra umiltà e modestia, nella superficiale omologazione che ci circonda – e nel brodo di mediocrità in cui molti sguazzano e pochi annaspano- le parole, raramente, vengono usate con perizia e coscienza del significato ponendo attenzione alle sfumature, le implicazioni e le adesioni a valori identitari, se lo si facesse più spesso si riconoscerebbe che l’umiltà è cosa ben diversa dalla modestia come l’intelligenza lo è rispetto alla furbizia: «È un salice piangente la modestia. È una quercia secolare l’umiltà» splendida metafora botanica che mi ispira un più prosaico: è una gatta morta la modestia, un fiero vessillo di verità l’umiltà.
Quanta profonda verità nelle considerazioni che fioriscono tra le pagine, come quella dedicata a chi nasce con il sacro fuoco della scrittura che mai lo abbandona e lo trattiene sul limitar del sonno per la paura di dimenticare quel pensiero, quella frase, quel dettaglio rincorso nel buio: «La mia festa più bella si è sempre svolta con le parole. È una febbre, la scrittura. A volte scende, altre sale, ma non passa mai».
Confermo, non passa mai. Il commiato dal lettore è affidato a una lettera di saluto al figlio Denis in cui lo esorta a vivere e a scoprire la bellezza dell’Italia perché: «L’Italia è apparentemente piccola ma capace di contenere tutto ciò di cui un individuo necessita: bellezza e calore. Arte e tradizione, cinema e natura» e a superare l’idea che certa critica abbia etichettato il suo lavoro come ricadente nel genere del romanzo rosa con sommo dileggio, invero cosa tutta da riscrivere questa dell’attribuzione di genere letterario come iscrizione sulla lavagna dei buoni e dei cattivi.
Brillante il gioco di attribuzione di sesso alle città, da partecipante al mio turno direi: Napoli inequivocabilmente donna per la sua rilassata bellezza fatta da infiniti dettagli stratificatisi nel tempo, Milano decisamente uomo per il suo rincorrere un obiettivo dimenticando la meraviglia dell’incantamento per le piccole grandi cose che ci circondano.
Se c’è una cosa veramente difficile è scrivere dando voce ai pensieri di un’altra persona rispettandone l’identità e, per quanto mi riguarda, Cesarini lo fa molto bene, trovo che la voce della “sua” Sagan sia, non solo, convincente, ma di più un omaggio nei confronti di una scrittrice e un atto d’amore verso una donna non comune.
©Riproduzione riservata
IL LIBRO
Isabella Cesarini
Le piace Proust?
96, rue de-La-Fontaine edizioni
Pagine 135
euro 16
L’AUTRICE
Isabella Cesarini scrive di cinema e letteratura. Ha collaborato alle pagine culturali di diverse testate online e cartacee; tra le sue pubblicazioni “Il cinema delle stanze vuote” (La Scuola di Pitagora, 2017), “Anime Inquiete. 23 storie per mancare la vittoria” (Auditorium, 2018), “Edificio Fellini. Anime e corpi di Federico” (Les Flâneurs Edizioni , 2019) e “Con la parola vengo al mondo. Bellezza e scrittura di Clarice Lispector” (Tuga Edizioni, 2021).