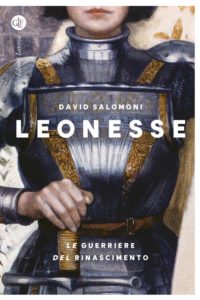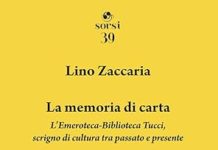Nel medioevo e nell’età moderna vissero donne d’armi, addestrate da padri, madri e nonne, alla strategia militare, la tattica e la battaglia. Di loro scrive David Salomoni in “Leonesse. Le guerriere del Rinascimento” edito da Laterza.
L’autore presenta una galleria di donne mostrando come, per depotenziarne le azioni, esse siano state descritte alla stregua di casi eccezionali – talvolta addirittura trasfigurate in figure romanzate – per tramandare una storia nella quale non loro – ma gli uomini che guidavano le truppe e gli eserciti- fossero la normalità.
Donne alla guida di soldati e in grado di organizzare una difesa, un attacco e costruire alleanze? No, non potevano avere le stesse abilità e essere investire dello stesso potere degli uomini, quel che potevano fare era distinguersi, talvolta, in circostanze particolari in cui il loro agire fosse assimilato alle caratteristiche maschili- coraggio, ardimento, intelligenza e arte del combattimento- in un’epoca in cui la conoscenza delle fortificazioni e delle peculiarità del territorio era importante quanto la numerosità degli eserciti.
Chi sono queste donne, le leonesse? Salomoni introduce lettori/trici all’argomento ricordando le condottiere regine d’Oriente Mavia e Zenobia, quelle del Nord Boudicca e Rometrude, la romana Galla Placidia, figlia di Teodosio I e sintesi tra il mondo romano e quello barbarico che da entrambi ricevette investiture di regalità e a cui i soldati tributarono totale e assoluta fedeltà.
Dopo di loro, e come esempio delle donne impegnate in attività militari tra le schiere dei Vichinghi, l’autore si sofferma sul ritrovamento archeologico di spoglie mortali sepolte con un corredo funerario di una persona dedita alla guerra avvenuto nel 1889 e solo nel 2014, in seguito alle analisi genetiche, attribuite a una donna, non una semplice guerriera ma una comandante intenta a usare pedine per studiare le strategie belliche.
Dopo di loro cita Jeanne de Monfort, soprannominata Jeanne la Flamme vissuta nella prima metà del Trecento e Isabel MacDuff, contessa di Buchan che, contemporanea di William Wallace e Robert Bruce, partecipò alle guerre di indipendenza scozzesi.
Il saggio prosegue con una attenta e documentata ricostruzione delle gesta delle donne d’armi italiane nel periodo medievale: «Molto spesso si trovarono ad affrontare situazioni estreme, difficili da immaginare per il lettore contemporaneo: assedi, battaglie, aggressioni. Come vedremo, però, malgrado l’ironia e il sarcasmo di cui talvolta furono oggetto, queste guerriere vissute tra il medioevo e il Rinascimento non si fecero mai trovare impreparate».
La galleria di donne presentate è accomunata dal vivere in una Italia centro settentrionale divisa in piccole realtà indipendenti perennemente impegnate a difendere le proprie terre dagli appetiti dei confinanti e dei regnanti europei.
Cresciute per saper cacciare, cavalcare, difendersi e guidare le truppe in battaglia tutte loro andarono in sposa a uomini scelti dalle famiglie per rinsaldare patrimoni e ottimizzare strategie difensive territoriali consolidando la proprietà di fortezze e castelli in grado di resistere ad assedi svolgendo un ruolo di sentinella sulle vie di passaggio della penisola italiana.
Mogli, madri e detentrici di un potere – ricevuto in assenza dei mariti o esercitato insieme con questi – organizzavano campagne militari, guidavano i soldati in battaglia e – quando insidiate dai nemici- si asserragliavano nelle cittadelle.
La prima che si incontra tra le pagine è Matilde di Canossa seguita da Marzia degli Ubaldini da Susinana, conosciuta anche come Cia degli Ordelaffi, la cui storia è legata alla città di Cesena e per la quale l’autore cita un passo che conferma quanto poco innanzi accennato in merito alla volontà storica di tramandare gesta femminili degne di nota etichettando le donne che le hanno compiute per essersi comportate come uomini.
«Nella Cronica dello storico Matteo Villani, vissuto all’epoca dei fatti, la condotta di Cia è definita ˂non come femmina ma come virtudioso cavaliere˃, a riprova del suo valore e del suo coraggio, oltre alla meraviglia che quelle gesta destarono tra i contemporanei». Un argomento, questo su cui l’autore si sofferma notando come gli storici, uomini, abbiano raccontato gli accadimenti in modo da svilire la vita e l’operato delle donne in armi: «Entrambi gli autori sono uomini (Ireneo Affò e Angelo Pezzana) ed è questo uno dei maggiori limiti della costruzione e trasmissione della memoria storica delle nostre protagoniste. L’accostamento alle regine dell’antichità e della mitologia permette di esaltare le gesta narrate e, allo stesso tempo, di relegarle a una dimensione mitologica, idealizzata, eternamente presente, eppure lontana e non minacciosa. In altre parole, paragonare Orsina e Bona, e con loro anche le altre guerriere, a figure del passato leggendario le depotenzia nella loro carica sovversiva. Esse cessano di rappresentare un possibile esempio per altre donne e assurgono a exempla virtutis per l’intera comunità con cui vengono identificate».
L’intento degli storici citati appare chiaro, sminare il potenziale emulativo dei modelli di riferimento positivo presentando le donne impegnate in fatti d’armi come casi isolati e lontani dalla normalità, del resto il termine virago ha una radice sanscrita vīrá e latina vir: uomo.
Salomoni, a testimonianza dell’importanza che attribuisce al tema vi ritorna nelle ultime pagine a proposito dell’uso del meccanismo della creazione leggendaria come forma di autoconservazione: «Per gli antichi (e per i moderni) le Amazzoni simboleggiavano il potenziale sovversivo e violento del mondo femminile, rimuovendolo ed esorcizzandolo. Relegare quella forza latente alla dimensione leggendaria estrometteva la capacità creatrice e distruttiva delle donne dall’interno di città e Stati, permettendo così, addirittura, di celebrarne le virtù. Una vera e propria catarsi. Si allontana ciò che è in noi, e ci spaventa».
Quel che spaventa è che possa profilarsi un modello sociale in cui la posizione di predominanza maschile venga messa in discussione, le donne – quando ne si vuole riconoscere talenti e passioni – sono assimilate agli uomini e assurgono alla dimensione di figure leggendarie non suscettive di creare proseliti e seguaci in grado di alterare lo status quo. «Il passaggio da persone di carne a persone di carta ha limitato l’esempio del potenziale eversivo femminile, confinandolo alle rassicuranti pagine dei cronisti, dei poeti, dei politici…».
In alcuni casi l’addestramento era materno, accadde per Orsina Visconti, Antonia Torelli e Donella Rossi rispettivamente madre, figlia e nipote appartenenti ai rami delle famiglie Visconti e Sforza distintesi sul campo. Ma non tutte le leonesse erano nobili, alcune appartenevano a famiglie dedite al lavoro della terra come Bona Lombardi e la ben più nota Giovanna d’Arco.
Furono donne dal carattere volitivo e l’intelligenza vivace, spesso dedite a coltivare interessi molteplici come nel caso di Caterina Sforza. Di lei leggiamo come da Castel Sant’Angelo tenne in scacco il pontefice rifiutando di obbedire all’ordine del marito di lasciare la rocca e successivamente della sfida lanciata dalla Rocca di Ravaldino assediata a chi, da sotto le mura la minacciava, compiendo un gesto scandaloso riportato da Nicolò Machiavelli: alzatasi la veste mostrò il sesso dichiarando che avrebbero anche potuto uccidere i suoi figli ma lei non avrebbe capitolato poiché aveva lo stampo- che metteva in mostra- per farne altri oltre quello che sarebbe nato di lì a qualche mese.
«Facendole alzare la gonna, Machiavelli pone Caterina all’interno di un complesso crocevia simbolico, a cavallo tra antichità e presente, tra mitologia e cronaca, tra sessualità e scaltrezza politica». Che l’episodio si sia realmente svolto o sia soltanto una finzione è meno importante del fatto che se ne abbia notizia perché, come dice Salomoni: «Caterina Sforza non fu solo guerriera e donna di potere ma, personalità poliedrica, si appassionò ai più svariati ambiti del potere. La Tigre di Romagna, in altre parole, era una donna colta, curiosa, intellettualmente audace. Non temeva di andare oltre i limiti della conoscenza ufficialmente concessa a una donna».
Nell’ultimo periodo della sua vita si interessò di alchimia, medicina e cosmesi scrivendo “Experimenti della excellentissima signora Caterina da Forlì” in cui affronta il tema del sesso dispensando consigli sia agli uomini che alle donne: «Insomma, l’opera di Caterina conferma la tendenza storiografica di un ruolo attivo delle donne nella produzione e circolazione di teorie e pratiche alchemico- scientifiche. Il libro degli Experimenti rappresenta uno spazio autonomo di potere femminile attraverso la conoscenza».
Ed è questa la chiave di lettura che il saggio suggerisce: la ricerca di una indipendenza delle donne attraverso la conoscenza, quella conoscenza loro negata, fatta eccezione per alcuni casi, in ragione del loro sesso. L’ultimo caso storico presentato è quello delle guerriere del Dahomey – regno africano rinvenibile nell’attuale Benin – un battaglione femminile creato nel 1729 e tramontato con l’avvento dell’imperialismo europeo del XIX secolo. È possibile, argomenta l’autore, che la nascita del battaglione sia una naturale conseguenza di una realtà preesistente e ipotizza che fossero cacciatrici esperte così come accadde per le donne d’armi italiane precedentemente presentate.
Un saggio interessante, che andrebbe introdotto nelle scuole, perché affronta il tema della storia militare italiana in un periodo storico in cui la belligeranza era pratica in uso per assicurare l’esistenza di ducati e piccoli stati indipendenti dell’Italia centrale con argomentazioni solide e una ricostruzione storica documentata basata su una teoria: gli storici hanno, scientemente, riportato gli accadimenti che vedono in donne a capo di forza militari come casi eccezionali – ammantati di aspetti leggendari – per impedire che questi fossero vissuti come possibili e ripetibili.
Sì -scrivono questi storici – alcune donne versate nell’uso delle armi sono esistite ma trattasi di casi sporadici che rappresentano una devianza dal modello sociale vigente che per esse prescrive altri ruoli. È tanto vero questo che solo dal 1999 le forze armate italiane consentono l’accesso alle donne, il 1999…
©Riproduzione riservata
IL LIBRO
David Salomoni
Leonesse. Le guerriere del Rinascimento,
Laterza
Pagine 227
euro 18,88
L’AUTORE
David Salomoni è docente presso l’Università per Stranieri di Siena. Ha lavorato nel Dipartimento di Storia e Filosofia della scienza dell’Università di Lisbona nell’ambito del progetto ERC Rutter: Making the Earth Global e nel 2022 è stato Berenson Fellow presso l’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies a Villa I Tatti. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Scuola, maestri e scolari nelle comunità degli stati gonzagheschi e estensi (Anicia 2017) e Educating the Catholic People: Religious Orders and Their Schools in Early Modern Italy (1500-1800) (Brill 2021). Per Laterza è autore di Magellano. Il primo viaggio intorno al mondo (2022) e Leonesse. Le guerriere del Rinascimento(2024).
Alcune delle figure storiche presenti tra #ledisobbedienti: