Lilia Giugni è una docente, una ricercatrice e un’attivista napoletana. Da diverso tempo vive in Inghilterra, insegnando tra le università di Bristol e Cambridge. Recentemente, ha pubblicato il libro: “La rete non ci salverà – perché la rivoluzione digitale è sessista (e come resistere)” (Longanesi, pagine 300, già recensito sul nostro portale da Francesca Vitelli nella rubrica Le disobbedienti), che ha conosciuto immediatamente un grande successo. Frutto di cinque anni di ricerca e impegno femminista, dall’opera emerge una brillante analisi sulla nostra epoca, puntando il dito sull’utilizzo del web e le molte ingiustizie che lo popolano. Ne parliamo con lei.

Chi sei e di cosa ti occupi?
Per mestiere faccio la ricercatrice e per passione faccio l’attivista. Sia nel mio impegno politico, sia in quello accademico, mi occupo di questioni di giustizia di genere, di giustizia sociale e delle loro intersezioni.
Una parte significativa dei tuoi studi si incentra sulla violenza di genere digitale. Perché ti sei appassionata a questo tema?
Per tanti motivi diversi, credo che la violenza di genere digitale sia l’ultima frontiera della violenza di genere. In primis, perché negli ultimi anni sono emerse forme completamente inedite di violenza machista sulle donne, che sono veicolate dalle nuove tecnologie. Penso, ad esempio, alla pornografia non consensuale, di cui parlo a lungo nel mio libro. Al tempo stesso, le nuove tecnologie canalizzano forme di violenza e di abuso che sono vecchie come il mondo. Mi riferisco alle molestie sessuali, al discorso d’odio, al razzismo, ecc. L’ausilio delle tecnologie permette a queste forme di abuso di moltiplicarsi e perdurare nel tempo. Negli ultimi anni poi, mi sono anche occupata dei meccanismi di monetizzazione di queste forme di violenza da parte dell’industria tech. Tutti questi studi sono poi confluiti nel mio lavoro più recente.
La tua analisi mette in luce una stretta relazione fra tecnologia, patriarcato e capitalismo. Ce ne puoi parlare meglio?
Guardo sia al capitalismo, sia al patriarcato come due logiche mediante le quali, da secoli, tendiamo ad organizzare la vita sociale. Sono due dinamiche che, pur manifestandosi in modi diversi, si sono a lungo intersecate nella storia umana. Basti pensare al fatto che il lavoro di cura non retribuito delle donne è servito a fare da stampella al sistema di produzione capitalista. Oggi, nell’era del capitalismo digitale, tratti del capitalismo e del patriarcato sono incisi a chiare lettere nel DNA delle nuove tecnologie e si manifestano nel modo in cui le produciamo, le distribuiamo, le utilizziamo. Questo è un po’ il cuore teorico della mia analisi politica.
Quindi, bisogna condannare le nuove tecnologie?
Non intendo demonizzarle. Quando dico che i tratti capitalistici e patriarcali sono incisi nelle tecnologie digitali, è forse utile specificare che non ho un approccio di tipo luddista. Dico semplicemente che nessun tipo di tecnologia sia neutrale. Al contrario, non può che riflettere, rispecchiare, moltiplicare i modi di agire della società in cui viene concepita. E, quindi, posto che la nostra società è sia patriarcale, sia capitalista, ecco che questi aspetti vanno poi a riflettersi anche in quell’ambito.
Alcuni temi da te analizzati vennero sollevati vent’anni fa dalle manifestazioni no global. Credi che quel movimento avesse intuito i rischi della rivoluzione digitale?
Penso che il movimento no global, all’epoca, sia stato profetico. O, meglio, non solo il movimento, ma anche le elaborazioni teoriche che l’avevano ispirato, come il postoperaismo, un certo tipo di femminismo degli anni’90, la critica postcoloniale, ecc. Quelli furono tutti input intellettuali e politici che hanno anticipato quanto vediamo accadere oggi.
Per esempio?
Mi vengono in mente le riflessioni del movimento no global sulla filiera di produzione del capitalismo o sul ruolo dei nuovi media sia nelle forme di oppressione, sia nelle forme di resistenza. Penso anche alle riflessioni sul carattere trasnazionale degli aggregati tecnologici ed economici. Oggi, purtroppo, alcune risposte che il movimento aveva immaginato in nuce sono state superate dalla realtà dei fatti. Penso allo slogan di Indymedia dell’epoca: “diventa tu il tuo media”. Attualmente, nell’era dei social network, quello slogan ha poco senso, perché bene o male tutti hanno accesso alle tecnologie e quella condivisione viene monetizzata e messa a profitto da grossi conglomerati industriali. Alcune di quelle intuizioni andrebbero recuperate e ampliate, soprattutto alla luce di quanto è successo dopo e anche di nuovi impulsi intellettuali e politici emersi in divenire, come quelli scaturiti dal femminismo della quarta ondata.
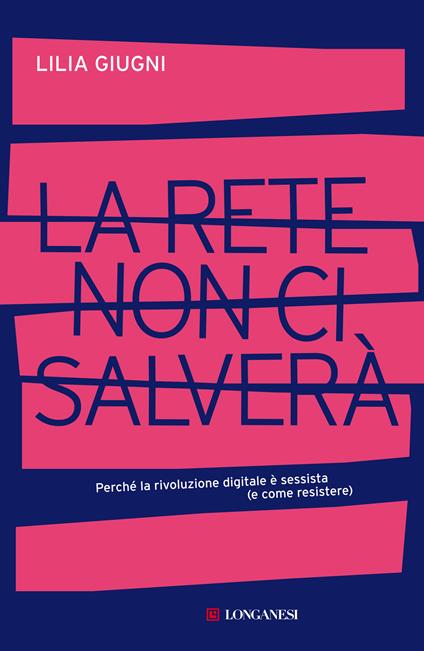
Eppure, la narrazione dominante demonizza il movimento no global. Pensi che si sia voluto scoraggiarne il portato politico?
A un certo punto, fra il 2000 e il 2010, è accaduto qualcosa. Nel Mondo, ma soprattutto in Italia. Penso che si sia interrotta la catena di trasmissione dei saperi e delle pratiche politiche antagoniste. Uno dei motivi di questa interruzione, naturalmente, risiede nel trauma di quanto accaduto a Genova nel 2001. Questa cesura avviene lì. Anche per questo mi fa piacere che, attorno al mio libro, da intendersi come un frammento di un fenomeno molto più ampio, si stiano intrecciando una serie di ragionamenti che si sono congelati vent’anni fa, che adesso vengono recuperati, ampliati e adattati al passare del tempo. L’altra cosa che mi fa ben sperare è il fatto che molte compagne e compagni più grandi di me, che hanno partecipato attivamente al movimento no global, mi stiano cercando per condividere stimoli e riflessioni.
In Italia, aumentano la crisi economica e la disoccupazione. Inoltre, si alternano esecutivi presieduti da tecnici voluti dalla Banca Centrale Europea a governi di destra. Come ti spieghi l’assenza di un movimento antagonista di massa?
Non abbiamo mai storicamente rielaborato il trauma del G8 di Genova. La repressione poliziesca ha svolto un ruolo fondamentale. In seguito, una generazione di militanti si è avvicinata alla politica con meno strumenti o non ci si è avvicinata affatto. A partire dal 2010, poi, abbiamo vissuto un’esplosione dell’attivismo digitale, che ha dei suoi aspetti positivi e anche insidiosi.
In che senso?
Oggi, la percezione dell’attivismo è molto diversa. Se pensiamo ai movimenti femministi, il modello imperante è quello di un attivismo molto individualizzato, che passa soprattutto dalla rete piuttosto che da esperienze di socializzazione politica e da lotte fisiche. Ovviamente, semplifico temi complessi. Ci sono generazioni molto giovani, piene di energie, che sentono di poter contribuire a migliorare il mondo semplicemente firmando una petizione online o condividendo un post sui social. Questo fenomeno è stato messo a profitto e monetizzato dalle piattaforme. Il che aiuta a spiegare perché non sia proliferato un movimento con le caratteristiche di cui parli.
Tra i punti cardinali della tua opera, parli di una disparità di genere nell’accesso alle risorse tecnologiche e, come accennavi prima, sostieni anche che l’industria tech non sia neutrale. Cosa intendi?
Sempre riassumendo temi complicati, guardo a tre tipi di ingiustizia di genere nell’era digitale, che si intersecano con l’ingiustizia di classe e quella razziale. Una, è la violenza veicolata dalle tecnologie, riferendomi in particolare alle forme di abuso. La seconda, ha a che fare con lo sfruttamento di chi lavora, soprattutto delle donne, a tutti i livelli della filiera di produzione del tech. Su questo aspetto, mi sono occupata delle lavoratrici della rete a tutti i livelli, dalle ingegnere che potrebbero democratizzare il web alle minatrici che estraggono i minerali per l’industria digitale. Il circuito di valorizzazione della tecnologia è intriso del sudore e del sangue delle persone. Il terzo filone di ingiustizie, infine, ha a che fare con la distribuzione, le diseguaglianze nell’accesso, il gap digitale di genere.
Che cos’è il “gap digitale di genere”?
È un indice che fotografa la diseguaglianza fra uomini e donne nell’accesso alla tecnologia. Me ne sono occupata particolarmente durante la pandemia, quando la mancanza di accesso alla tecnologia aveva conseguenze più gravi per le donne, perché significava che fossero impossibilitate a studiare, a lavorare o a denunciare un compagno violento. Nel mio lavoro, da un lato, illustro le ricadute pesantissime delle tecnologie, poi però dico anche che la tecnologia è un passaporto indispensabile per vivere la vita contemporanea. Nel momento in cui non vi hai accesso, sei ancora più subalterno, vulnerabile, oppresso.
Nel libro, scrivi che la violenza di genere online viene spesso utilizzata come una strategia per costruire consenso politico. In che modo?
Faccio una piccola premessa. Finora abbiamo parlato dell’impianto teorico del mio libro, ma non ho scritto un trattato accademico. Piuttosto, quello è un libro di storie di vita vissuta da donne -molto diverse fra loro per classe, etnia, religione – che però hanno in comune una condizione di oppressione. La mia ricerca si ispira alla grande eredità del pensiero femminista del ‘partire da sé’.
Ci puoi fare qualche esempio?
Penso agli Stati Uniti di Trump, coi casi di Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar, oppure al Brasile di Bolsonaro, sfidato dal coraggio di donne come Patrícia Campos Mello. Penso all’India di Modi col caso di Rana Ayyub. Ma altri esempi di violenza di genere online li troviamo anche nell’Italia di Salvini o nella Russia di Putin, in cui il Cremlino perseguita attiviste e giornaliste. Questi sono alcuni dei molti esempi che si potrebbero fare, ma è importante capire il meccanismo che c’è dietro e rimane sempre lo stesso.
Qual è il meccanismo con cui si riproduce la violenza di genere digitale?
Narrazioni politiche infarcite di machismo, che passano per la rete e per i social e sono finalizzate ad accalappiare specifici settori della popolazione maschile, appartenenti a segmenti dominanti – etnici, razziali e religiosi- nei paesi di appartenenza. Sulla base di queste narrazioni, nel tempo, tutta una serie di attori politici ha individuato specifiche donne, selezionandole come capri espiatori per compattare e mobilitare il loro seguito online. E questo non solo per “silenziare” la donna scelta come bersaglio, ma per attivare un’operazione di tipo squadristico – i cosiddetti shitstorm– per tenere i seguaci in uno stato di mobilitazione permanente. Anche se oggi si inizia a parlare di violenza digitale e di violenza digitale di genere, non se ne parla nei canoni giusti, inquadrando i fenomeni reali. Ci si sofferma sul caso individuale, ma il cosiddetto “leone da tastiera” o troll (in inglese) che scrive messaggi di odio, è solo una pedina in un gioco molto più grande. Dietro c’è il meccanismo di costruzione del consenso politico e le strategie di monetizzazione da parte delle piattaforme.

Come funzionano queste strategie di monetizzazione?
Ogni piattaforma ha un business model. Quasi tutte le piattaforme traggono profitto dall’estrazione di dati da parte dell’utenza. Questi dati vengono trattenuti e poi, elaborati con sofisticati strumenti. Il risultato è la produzione di previsioni, o predizioni, delle nostre preferenze e dei nostri futuri comportamenti online. A partire dai nostri click, le piattaforme sono in grado di desumere come ci comporteremo online in futuro. Queste previsioni sono messe a disposizione dei clienti paganti delle piattaforme, che sono i brand che ci inviano messaggi pubblicitari.
Quindi, anche la violenza di genere digitale è un affare per queste piattaforme?
Certo. Affinché questo business model regga, è indispensabile mantenerci incollati alle tastiere a produrre dati e assorbire messaggi pubblicitari. Le piattaforme si servono di vari espedienti per farlo. Il primo, è la manipolazione algoritmica dei contenuti, che tende a favorire la circolazione di argomenti controversi o divisivi. Il secondo espediente, invece, ha a che fare col mostrare contenuti simili a quelli che l’utente ha visualizzato in precedenza. Questo gioco ha un ruolo d’importanza capitale nella radicalizzazione di attori politici e nella propagazione di odio e abusi, perché più gli utenti visualizzeranno contenuti sessisti, misogini, razzisti, più ne visualizzeranno in futuro. Dietro ogni troll ci sono meccanismi colossali di natura politica e tecnologico-economica.
Cosa si può fare, allora?
Intervenire su queste dinamiche. È assolutamente indispensabile agire sulla regolamentazione delle campagne elettorali digitali. Inoltre, è fondamentale incentivare interventi educativi a tappeto nelle scuole e nelle università, come arma di autodifesa digitale, di cui hanno già parlato attiviste come Naomi Klein. L’altra questione rimane un intervento di policy, finalizzato al responsabilizzare le piattaforme digitali rispetto alla loro utenza e a chi lavora per esse. Questi interventi mirati possono spezzare il legame insidioso che si è creato fra grande industria tech e forze politiche, soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi occidentali. Per questo sostengo che il libro che ho scritto è sì uno strumento di lotta, ma va molto al di là di me. Più che altro, interpreta un bisogno di discutere di questi temi e una necessità di organizzarsi.
Visto che parliamo dell’utilizzo della tecnologia ai fini della costruzione di consenso politico, come spieghi il successo di Giorgia Meloni?
Meloni si muove in modo particolare rispetto ad altri. Si differenzia anche da Matteo Salvini, che era quello che prima di lei aveva utilizzato di più le nuove tecnologie per fini politici. In un recente articolo, parlavo della scelta della Meloni di condividere sui social un video di uno stupro commesso a Piacenza, pare da un richiedente asilo proveniente da un paese africano. Quell’azione lì corrisponde perfettamente al meccanismo che abbiamo discusso sopra. La condivisione del video intendeva polarizzare ulteriormente il dibattito e mobilitare il suo seguito online utilizzando una nozione classica del partito e del movimento di Meloni: la caccia allo straniero brutto e nero, che stupra una nostra donna. Per ottenere questo obiettivo, lei non si è fatta scrupoli di buttare a mare un’altra donna, la vittima dello stupro, anch’essa straniera. Questo episodio dimostra, da un lato, come la Meloni non si faccia scrupolo di utilizzare le tattiche digitali per costruire il suo consenso. D’altra parte, è interessante osservare anche come lei, di volta in volta, declini il suo essere donna anche contraddicendosi. Sicuramente, ha una chiara consapevolezza del come funzioni la politica sui social e una certa originalità anche nel declinarlo.
Recentemente, a Cuba è stato introdotto un nuovo Codice per le famiglie, testo in cui si afferma la piena uguaglianza fra i generi. In Italia, invece, si è mai pensato di introdurre nel diritto di famiglia la discriminazione di genere come reato penale?
Riguardo al caso cubano, parliamo di molteplici interventi che dovrebbero andare a parificare la condizione delle persone e delle famiglie LGBTQ+ rispetto alla legge. La nostra legislazione, invece, in materia di questioni di genere appoggia su un apparato giuridico complesso e problematico. Lo dico da politologa, non da giurista. Da un lato, abbiamo una Costituzione mediamente progressista, che è frutto di un compromesso fra le forze politiche scaturite dalla seconda guerra mondiale. Dall’altro, abbiamo il Codice Rocco, che è di matrice fascista e ci lascia un’eredità profondamente sessista e oppressiva, che è stata rimossa a fatica dal nostro ordinamento giuridico, grazie alle lotte collettive delle donne e dei loro alleati. Quell’eredità, però, si sente ancora e si evince non solo nel dettato legislativo, ma anche nella cultura di formazione del personale legale, giudiziario e delle forze dell’ordine.
Cosa intendi?
Da femminista tocco un argomento divisivo fra i femminismi. Sono tendenzialmente contraria a un’iperlegislazione in proposito. A me, il femminismo penale e giudiziario non appassiona e lo trovo, alla lunga, controproducente. Naturalmente, riforme penali e interventi legislativi che istituiscano nuove fattispecie criminose sono necessarie e vanno incoraggiate, come nel caso della pornografia non consensuale, moltiplicata a dismisura grazie alle nuove tecnologie. Tolti questi casi, però, serve fare un uso migliore della legislazione già esistente. Il principio di non discriminazione sulla base di genere esiste già in Costituzione, la legislazione sulla violenza di genere e gli obblighi derivanti in materia per istituzioni e privati cittadini e cittadine, ci viene dalla Convenzione di Istanbul. Il problema, dunque, è l’educare il personale legale e giudiziario a un buon utilizzo di questa materia legislativa, perché se le leggi le abbiamo, ma vengono ignorate, ci servono a poco. Infine, ci servono interventi educativi volti alla prevenzione.

Com’è messo il nostro Paese sul versante dei diritti civili?
L’Italia è molto indietro. Mi viene in mente la battaglia sul disegno di legge Zan, che non era una riforma o una legge perfetta. Tra l’altro, si appoggiava a un istituto come la legge Mancino, che è a sua volta un testo problematico. Visto, però, che quella legge disciplinava il discorso d’odio motivato dall’etnia, dalla razza, dalla religione e non dal genere, dall’identità sessuale o dall’orientamento sessuale, ci trovavamo di fronte a una situazione discriminatoria ed era opportuno colmare questa lacuna, cosa che non è avvenuta. Poi certo, si ha l’impressione che questi interventi “a costo zero”, per chi legifera, siano provvedimenti spot.
Cosa occorrerebbe?
Per le donne e per le persone LGBTQ+, gli interventi realmente necessari sarebbero quelli rivolti ai bisogni materiali. Tornando al ddl Zan, la parte più interessante di quella proposta legislativa era quella che stanziava fondi per le vittime della violenza omolesbobitrasfobica o per campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Questo tipo d’intervento ha dei costi e non paga molto dal punto di vista della propaganda di chi legifera. Eppure anche di questo abbiamo un disperato bisogno.
A che progetti stai lavorando?
Per me, il lavoro di ricerca è inscindibile dall’attività politica. Per onestà intellettuale e politica, non potrei mai dedicarmi a un lavoro di ricerca avulso dalla realtà e dalle lotte, che non sono mai individuali, ma collettive. Tutti i miei progetti hanno una relazione con le battaglie di cui faccio parte. Certo, sono consapevole che chi fa ricerca si muove nel contesto dell’università neoliberale con le derive che ne conseguono. Ma non per questo demordo. Per i prossimi mesi, prevedo di contribuire e coordinare laboratori, incontri in spazi occupati e nelle case delle donne o nelle scuole. Per quanto riguarda altri stimoli che vorrei sviluppare, è da un po’ che ragiono sul tema dell’utopia, che recupera l’ultima parte del mio libro. Niente di tutto questo è realmente utile se non riprendiamo ad esercitare il muscolo dell’utopia.
È un’immagine potente. Cosa significa?
Rispetto a quello che accadeva col movimento no global, appartengo a una generazione che si riteneva cresciuta nel tramonto delle utopie. A noialtri, avevano spiegato anzi che le utopie erano pericolose, che non esistevano altri modi di organizzare la realtà, la società, l’economia rispetto a quelli esistenti e che, se c’erano, erano indesiderati. C’avevano detto che tutto sarebbe andato bene, che la rete c’avrebbe salvati, che l’Occidente si avviava verso sorti magnifiche e progressive… Non è stato così! Il movimento no global l’aveva intuito e oggi raccogliamo i cocci di questa situazione. Tutto quello che abbiamo assorbito in questi decenni c’ha portato a bloccare il muscolo dell’utopia, cioè l’immaginare modi alternativi di organizzarci e di sognare qualcosa che ancora non c’è. È un tema su cui mi interessa riflettere, che parte dall’idea delle utopie femministe che riguardano le città. È una suggestione interessante, perché vorrei cercare di guardare a come nella storia ci sia stata una dialettica fruttuosa, virtuosa, tra immaginazione radicale rivoluzionaria e pratica politica. Cosa su cui mi interessa riflettere non da sola, ma in ambito politico e collettivo.
Per concludere, quanto è urgente in Italia riprendere un movimento di giustizia sociale e di genere?
È urgentissimo. Certo, ci sono già tante sacche di resistenza, ma putroppo non sono collegate fra loro. Uno dei temi su cui mi concentro, è il ricostruire i legami fra i diversi movimenti che lottano contro le oppressioni di genere, di razza, di classe, di coscienza ecologica. Bisogna connettere i puntini fra queste varie forme di resistenza all’ingiustizia, all’oppressione, alla marginalizzazione, che sono in realtà collegate fra loro. L’altra cosa da fare subito nell’intera società, a partire dalle persone molto giovani, è la creazione di consapevolezza e alfabetizzazione rispetto a ciò che sono i circuiti di valorizzazione della tecnologia e delle interazioni online. Giro da qualche mese per parlare di questi temi. Mentre riscontro tanto interesse, tanta voglia di impegnarsi, comprendo anche che su questi temi ci sia poca consapevolezza politica.
La rete non ci salverà, ma noi possiamo cambiare la rete?
È ciò che mi auspico. Nei prossimi mesi, la Commissione europea dovrebbe concludere l’iter legislativo su alcuni provvedimenti, il Digital Markets Act e il Digital Services Act. Questi sono dei piccoli passi avanti che interverrano nel regolamentare il funzionamento delle piattaforme, ma d’altra parte interverranno anche in maniera drammatica su tanti aspetti delle nostre vite, della nostra società, della nostra economia e della nostra cultura politica. In Italia, non se ne parla, se non su testate come Il Sole 24 ore, che sono molto tecniche e poco politiche. Il fatto che non ci sia una politicizzazione su questi temi, comporta che non si apra una vera dialettica politica sui processi in atto. Anche su questi punti è urgente muoversi e lavorare.
©Riproduzione riservata










