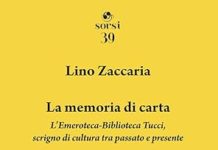«Non voglio essere solo una madre, è finito il tempo in cui le donne devono restare chiuse in casa a guardare pentole e figli». A pronunciare queste parole è Anna Kulišëva, conosciuta in Italia come Anna Kuliscioff, (1854(?) – 1925) nella biografia, da pochi giorni in libreria per Neri Pozza, che Pierfrancesco De Robertis ha dedicato a lei e Filippo Turati.
Una rivoluzionaria di origini ebree nata in Crimea e scappata per fare della politica il modo per cambiare la società e il mondo. Anticonformista, brillante, intelligente e tenace, come l’autore spesso ricorda: una cosacca. Il libro si apre con il suo arrivo, nel 1884, a Napoli insieme con la figlia di tre anni.
Il padre, compagno di lotta, è Andrea Costa. Il soggiorno partenopeo è finalizzato al conseguimento della laurea in medicina, cosa non facile poiché le donne che volevano iscriversi all’università dovevano superare il pregiudizio secondo cui lo studio e l’esercizio della professione fosse cosa da uomini tralasciando nel caso di specie, un precedente storico risalente al medioevo: la scuola salernitana delle Mulieres con Trotula de’ Ruggiero, Rebecca Guarna, Sabella Castellomata, Margherita della Mercuriade, Venturella Consinata e Costanza Calenda.
Il percorso di studi fu sospeso dalla rottura del legame affettivo con Costa e la conoscenza dell’uomo con cui avrebbe diviso la vita e le battaglie politiche, Filippo Turati, che seguì a Milano. Per le vicende della storia nello stesso ateneo federiciano, dieci anni dopo, si sarebbe laureata un’altra donna di origini russe impegnata nella ricerca, la carriera accademica e la battaglia politica, Maria Bakunin, figlia del rivoluzionario Michail con cui Anna Kuliscioff intratteneva una corrispondenza, quella di Maria è un’altra storia di disobbedienza.
Kuliscioff, che aveva già conosciuto il carcere, la fuga e la solitudine di una madre non sposata che cresce una figlia con un padre assente, trovò in Turati un compagno con cui condividere amore e una dimensione familiare il cui fulcro non era il matrimonio ma la saldezza degli affetti e la passione socialista del sol dell’avvenire: «Vede, padre, non hanno argomenti, e dunque mi attaccano sul piano personale. Perché si deve dire che ho avuto una relazione intima con Costa e adesso con Turati? E perché sono così ipocriti da chiamarlo amico? Che importanza ha? Di un uomo direbbero con chi è sposato, con chi vive, con chi ha figli? […] “No, Filippo, io devo lavorare. È il lavoro che dà a una donna la libertà, la possibilità di vivere alla pari dell’uomo. La rivoluzione inizia dai gesti quotidiani».
Kuliscioff credeva nell’indipendenza economica, di pensiero e di azione e per tale motivo giunta a Milano prima di continuare gli studi decise di lavorare, molte delle considerazioni che si leggono tra le pagine risuonano – purtroppo – ancora attuali.
È il caso della prima battaglia politica che vuol portare avanti e discute con Turati e gli altri compagni per far comprendere che il socialismo non doveva perseguire solo i diritti degli uomini ma anche quelli delle donne e – pertanto- bisognava impegnarsi per raggiungere la parità salariale, migliorare le condizioni di lavoro e riconoscere loro il diritto di voto: «Voi non capite. Quando c’è da mettersi a guidare uno sciopero sono le prime. Ai seggi non possono entrare ma la polizia non si fa problemi a rinchiuderle in una cella per essere state in prima fila nelle proteste. Se le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini e non guadagnano come loro, metà della società resterà indietro».
Ancora oggi, mi tocca spiegare, dati alla mano, cosa significhi in termini di mancata generazione di Pil l’esistenza del differenziale salariale, dei percorsi di carriera frammentati e precari delle donne e il loro mancato accesso in determinati segmenti e a determinate posizioni nel mercato del lavoro.
Per un periodo, fin quando la salute glielo permise, Kuliscioff prestò cure alle donne malate spronandole ad assumere una visione diversa: “Proprio le donne erano le prime a dare per scontata la supremazia dell’uomo, a non riuscire nemmeno a immaginare un futuro diverso. C’era molto lavoro da fare” e tanto ce ne è ancora…se la sua salute era minata dalla tubercolosi quella del suo compagno di vita era insidiata da un pernicioso mal di vivere manifestatosi in giovane età che lo accompagnò, acquattandosi nell’anima, fino alla fine dei suoi giorni.
Lei lucida e votata all’azione, lui riflessivo e portato alla mediazione scrissero insieme con Leonida Bissolati, Claudio Treves, Giuseppe Emanuele Modigliani, Pietro Nenni e Giacomo Matteotti la storia del socialismo italiano. Nonostante gli svariati tentativi di proseguire il percorso accademico altrove per conseguire la laurea tornò a Napoli, una città che l’autore descrive, non comprendo per quali motivi, come “camorrista e ipocrita”.
La dinamica di coppia di cui leggiamo si fonda sulla forza di carattere di una donna, con una chiara visione sociopolitica, e un uomo che vuol credere nella ragione degli esseri umani e si affida alle sue doti analitiche. Trascorsero insieme quarant’anni, furono arrestati, crebbero la figlia Anna, piansero per la morte dei compagni falcidiati negli scontri e soffrirono, come ne fossero genitori, per l’orrendo assassinio di Giacomo Matteotti. Nelle pagine si avverte la tensione di Kuliscioff che rimane nella casa milanese a scrivere consigli e suggerimenti a Turati che siede in Parlamento a Roma, decisa e determinata lei, possibilista e mediatore lui.
La loro differente personalità si evince, chiara, nel giudizio espresso nei confronti di Benito Mussolini: per lei una minaccia, per lui un avversario politico con cui poter mediare. Anna Kuliscioff non vedrà la fine del fascismo e l’esilio di Turati che, insieme con Pertini, Rosselli e Parri scappò in Francia.
L’autore propone una doppia biografia documentata e circostanziata che ha il pregio di mantenere in fluido equilibrio due piani della narrazione: quello personale, intimista, della vita dei protagonisti, e quello storico delle vicende avvenute in Italia dalla fine dell’Ottocento alla metà degli anni Venti del secolo scorso.
Una lettura consigliata per ricordare la storia del nostro Paese e le vite di donne e uomini che tale storia la fecero e, non meno interessante, per ricordare che si possono avere idee diverse senza essere nemici, anzi al contrario, che sulla differenza si possono costruire rapporti umani solidi e duraturi quando basati sul rispetto reciproco e l’onestà intellettuale che porta a riconoscere i propri limiti e quelli altrui.
Kuliscioff e Turati non andavano d’accordo su tutto, discutevano e si infervoravano, avevano punti di vista diversi ma condividevano una visione del mondo che era il terreno comune sul quale incontrarsi.
©Riproduzione riservata
IL LIBRO
Pierfrancesco De Robertis
Un amore socialista
Neri Pozza
pagine 544
Euro 22
L’AUTORE
Pierfrancesco De Robertis è giornalista. È stato direttore de La Nazione di Firenze e scrive per varie testate nazionali. Un amore socialista è il suo primo romanzo.
Tra #ledisobbedienti:
le biografie tra #ledisobbedienti: